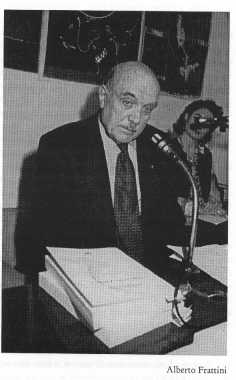Dal n° 211 della rivista Fermenti
Alberto
Frattini
Io
ho avuto il vantaggio di intervenire qui per terzo: e importante questa dizione
della poesia di Piazzolla che ha fatto adesso Maestosi, il quale ha dato
un'interpretazione eccellente. Devo dire che pareva, appunto, di entrare in
questo spirito magico di Marino', e anche la scelta mi pare ottima, perché le
poesie di Piazzolla sono molte ma alcune hanno delle caratteristiche tutte
particolari. Comunque anche in quelle che abbiamo ascoltato ci si sente qualcosa
di tipicamente suo, proprio di piazzolliano, e questa e un po' la caratteristica
dei
poeti
autentici.
lo
sono ben lieto di essere qui per dare testimonianza a questo poeta che ho avuto
il piacere di conoscere tantissimi anni fa. Per ragioni anagrafiche sono quello
che lo conosceva da più tempo, perché io lo incontrai negli anni Cinquanta. Ho
sentito l'inizio di questa lettura che ci riportava alle Elegie doriche che
sono del 1952 ed io ricordo che il mio primo intervento, la mia prima recensione
apparve proprio in quell'anno, nel '52, quando Marino (che, venuto a Roma,
cominciava ad ambientarsi e a scrivere) aveva pubblicato questo primo libro.
Questo libro ebbe indubbiamente notevoli consensi, anche se la sua era una voce
discordante, una voce diversa. Basti pensare al titolo Elegie doriche: eravamo
negli anni '50, il periodo in cui veniva su una poesia di segno diverso, una
poesia di impegno, una poesia aperta al turbinoso incalzare dei fatti storici,
una poesia anche, a volte, ricca di tensioni di segno populistico. Non sono
poche le poesie di quel tempo che non si ricordano più, appunto perché avevano
buone intenzioni ma non si concretarono in poesia autentica, quella che deve
avere una sua trasparenza, una sua affilatezza, una sua capacità di entrare
dentro l'uomo e la sua vita.
Credo
che la caratteristica di Piazzolla sia quella di aver sempre seguito questa
linea di autenticità. Le sue poesie nascono tutte, profondamente, dal vissuto;
come è stato detto poco fa, la sua lirica e la sua poesia in generale, hanno
diversi aspetti, diverse facce, sono poliedriche e su questo siamo d'accordo, ma
perché? Appunto perché c'è una linea lirica e abbiamo ascoltato alcuni testi
che rappresentano in maniera molto alta questa dimensione. C'è anche questa
tensione al reale e ci sono persino, variamente sviluppate, altre tensioni di
segno, per esempio, civile. C'è, insomma, il Piazzolla che segue anche le
vicende della cultura, che poi diventa polemico nei confronti della cultura
contemporanea, un Piazzolla non soddisfatto dai poeti, né dagli scrittori, né
dai pensat6ri del suo tempo. E questo Piazzolla io ho avuto modo di conoscerlo
più a fondo grazie a quest'opera, che ho qui davanti a me e sulla quale posso
dire alcune brevi cose: uno degli autori, importante perché è stato colui che
si èdedicato alla ricerca di testi ormai introvabili, è VeI io Carratoni che
spiega nella breve introduzione al primo volume, le ragioni, i modi oltre che il
destino di questo singolare scrittore e poeta, come fa, un po' più avanti il
nostro amico Spagnoletti, presidente attuale della Fondazione Piazzolla.
Accettando
l'incarico di fare l'introduzione a questo libro, ricordo che mi sono rituffato
anch'io nello studio e nell'approfondimento di tutto Piazzolla ed è venuto
fuori un Piazzolla che conoscevo anch'io meno bene, cioè il Piazzolla critico,
studioso di letteratura italiana, lo scrittore che segue e interviene su
scrittori e poeti del suo tempo, a volte coetanei, a volte poeti che vivevano
anche a Roma, come ad esempio Cardarelli.
lo,
a volte, frequentavo Cardarelli, proprio negli anni '50, quando Piazzolla
interveniva in questa magnifica via di Roma che è Via Veneto, vicino a Porta
Pinciana. Cardarelli si fermava davanti allo Strega e si tratteneva lì; a volte
d'estate rimaneva fermo anche per delle ore sotto il sole con il cappotto, tanto
che qualcuno diceva: che succede? Aveva uno strano male per cui aveva bisogno
sempre di avere molto caldo e quindi anche d'estate teneva addosso il cappotto.
Ed era lì che ci vedevamo insieme anche con Piazzolla e si conversava, si
parlava, di solito Cardarelli era un po' scontroso, sebbene abbia avuto
addirittura un periodo di sodalizio con Piazzolla che poi dopo si è interrotto.
Carratoni sa bene queste vicende perché ha pubblicato alcuni interventi sulla
sua rivista Fermenti.
Il
merito di questo libro, di questa ricostruzione, direi, puntigliosa e quasi
completa, anche se qualcosa è rimasto fuori, ovviamente, è quello di offrire
un po' un "Tutto Piazzolla", si può dire, almeno nelle grandi linee,
cioè il Piazzolla poeta, il Piazzolla prosatore, il Piazzolla critico, il
Piazzolla anche francesista.
Io
ho scritto, e naturalmente confermo questa mia impressione, che non si può
parlare che impropriamente, ma orientativamente, di un Piazzolla francesista;
comunque conosceva molto bene il francese, la lingua e anche la letteratura, e
interveniva, naturalmente non sistematicamente. Del resto anche Carratoni
avverte che in Piazzolla mancava questa capacità di fermarsi su un settore e
andare in profondità per costruire qualcosa di profondo. Nell'insieme è
interessante perché, oltre che critico, è anche uomo di pensiero. Lo dimostra
il fatto stesso che affronta uno scontro, se non proprio un incontro, con Sartre
e scrive saggi, interviene, difende le sue posizioni e lo accusa, e addirittura
critica tutta la cultura italiana, addirittura fa una specie di disamina molto
severa verso la cultura del nostro tempo.
Di
argomenti per sostenere questo ce ne sono moltissimi perché la nostra storia,
quella che va dalla fine della guerra ad oggi, è una storia ricca di vicende
tumultuose, turbinose, contraddittorie. Indubbiamente il nostro è un Paese che
ha durato fatica ma che ha dimostrato anche qualità in positivo nella ripresa.
Pensate all'italia che addirittura arriva al boom dopo gli anni durissimi che
seguono alla guerra, gli anni '45-'50-'55, che noi abbiamo vissuto.
Ricordo, ero professore delle scuole medie superiori e avevamo degli stipendi
veramente da fame; vinsi la cattedra nel '54 per le medie superiori ed ero
l'unico professore che a Terni andava due volte a pranzo. Non si vedeva nessuno
la sera, ero l'unico che andava al ristorante e mi dicevano: come mai? lo
collaboravo, proprio in quegli anni, a Il Messaggero, e allora dicevano:
tu sei ricco, sei un signore!
|
In
realtà cominciai molto presto, a trenta-trentuno anni, a fianco di
Bellonci che non mi vedeva, naturalmente, di buon occhio, diceva:
"Questi giovani critici..." Prendevo trentamila lire ad articolo
e come stipendio avrò avuto sulle trentacinque-quarantamila lire al
massimo, quindi questo mi dava delle possibilità . Ma, per dire, era un
momento drammatico, anche per gli studi, per poter approfondire, dedicarsi
di più ad essi. C'erano molti amici che si dedicavano alle lezioni, alle
ripetizioni e questo, naturalmente, li portava fuori dall'approfondimento.
In
quegli anni noi conobbi Piazzolla e capii subito che era un poeta di
razza, anche perché a lui non interessava niente, lui faceva il
professore, insegnava filosofia. L'ho incontrato molte volte. lo lo andavo
a trovare quando abitava in Via Frattina e aveva una sua attività,
perché lavorava a tutte le ore, anche fuori, lavorava sempre, preparava
questi suoi poemetti. Quello che è stato letto in parte da Maestosi è
uno dei più belli, dei più famosi, le Lettere de ha sposa demente,
che anch'io lessi con grande sorpresa, era un opera nuova, in certo modo,
direi che la cultura francese lievitava in maniera diversa. |
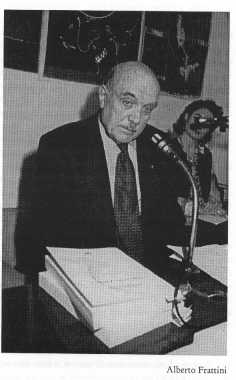 |
Si
è detto che l'italia non ha avuto una poesia dl simbolisti, in realtà è stata
fatta una ricerca. Come mai da noi manca una poesia dove incida fortemente
questo segno del simbolismo-decadentismo? Per diverse ragioni. anche perché,
effettivamente, la nostra tradizione è molto forte e noi abbiamo alle spalle
Carducci, D'Annunzio, che certo non erano buoni maestri. Pensate a come Thovez,
nel primo novecento liquida Carducci, D'Annunzio e persino Pascoli e risale a
Leopardi, perché Leopardi è il nostro grande centro! E Leopardi mi richiama
ancora Piazzolla, perché io che cominciavo già da allora ad occuparmi di
Leopardi, e me ne sono occupato poi per quarant'anni di seguito, posso dire che
Piazzolla quando intervenne negli anni Sessanta su La Fiera Letteraria, scrisse
un articolo su Leopardi che, nel suo genere, è un articolo intelligente, un
articolo, direi, anche oggi utile, un articolo in cui non ci sono profondità di
scavo nuovo, ma c'è l'intuizione del poeta.
Piazzolla
capiva in quegli anni, quando già era partita la nuova corrente di studi
leopardiani, questo nuovo corso, dove Leopardi si voleva presentare nella linea
dell'interesse per il progresso. Leopardi progressista di Luporini, per
intenderci, che certamente fu una corrente interessante, utile perché sommosse
le acque del leopardismo tradizionale ma, naturalmente, il pericolo fu quello di
agganciare Leopardi al carro di una poesia di impegno sociale che proprio non
c'è, non esiste. Del resto, questo lo sapeva benissimo anche Luporini, il quale
parlò di "progressivo" e non di "progressista".
Piazzolla
scriveva negli anni '60 che Leopardi era un grande poeta e diceva: <<Quello
che importa in lui è la globalità del fondo da cui sorge la sua poesia",
il che è esatto. La sua poesia raccoglie, stringe ed esalta tutto l'uomo e
tutto l'universo nell'uomo- È questo il punto, non si può isolare questo o
quell'aspetto! E diceva giustamente: si cerca di impugnare la sua improbabile
religiosità, il che non e accettabile. Da quarant'anni ho cercato di dimostrare
che in Leopardi non è vero che è cancellata la parola "spirito", è
cancellata la parola "divino", ècancellata la parola e il concetto di
"sacro".
In
Leopardi c'è questo concetto di sacralità della poesia cheper altre strade
ritorna anche in Piazzolla. Egli ha scritto una pagina acutissima su questo
aspetto del religioso, ma un religioso, badate bene, laico, non confessionale,
che è la strada più giusta per chi si occupa di poesia. Altra cosa è poesia e
altra cosa è la preghiera, indubbiamente ci sono nessi ma non è la stessa cosa.
Tanto per farvi sentire anche un Piazzolla prosatore e per portarvi la sua
intuizione dell'arte in rapporto al principio della trascendenza, ecco questo
Piazzolla che si sofferma sulla sua poesia nella dimensione del religioso:
"lì mio far poesia" - scriveva -"deriva essenzialmente dal pormi
in rapporto con l'uomo, la natura e Dio che ritengo tre realtà trascendenti la
mia persona. Più che nelle correnti artistiche credo nelle opere che hanno una
loro compiutezza sia storica che metastorica. Tutto quello che di autentico un
poeta riesce a rappresentare non lo attinge che dal "Sacro"; perciò
l'arte che ha una maggiore durata storica ed un valore universale discende
direttamente, o per vie misteriose, dalla trascendenza. Siamo nell'Essere e non
possiamo evadere da questa totalità>>.
Ancora
"totalità", come io già avevo detto per Leopardi; anche in Piazzolla
è molto chiaro questo concetto della globalità, della totalità,
dell'assolutezza dell'Essere cui l'occhio del poeta guarda, al di là della
contingenza e punta ai valori che la trascendono. In questo senso direi che
abbiamo in mano già una chiave per capire anche gli sviluppi della poesia di
Piazzolla, che si articola in maniera molto varia. I suoi libri hanno questa
ricchezza, direi caleidoscopica, di invenzione, di prospettive, di spunti, egli
scrive addirittura un libro legandosi a grandi poeti che ha amato, a musicisti
ecc. Oppure inventa e mette su dei poemi, fino ad arrivare a delle soluzioni e a
delle proposte che sembrano quasi inimmaginabili per un poeta come lui, un
libertario.
Ripenso
a quella specie di carme o inno che scrive per un patibolo chiamato Piazza
Loreto, una poesia che non conoscevo e che mi ha veramente colpito. Mi pare che
abbia fatto bene Carratoni a propormela perché io ho potuto anche tenere conto
di questo, perché lui libertario, aperto e quindi evidentemente portato contro
tutto quello che era collegato agli aspetti autocratici, impositivi, coattivi
del fascismo, ad un certo momento insorge contro questa brutalità della massa
che improvvisamente si accende sui cadaveri di questi due personaggi che vengono
appesi a Piazza Loreto e gli sembra una cosa assurda.
Piazzolla
capiva benissimo che quella era la folla, la folla che diventa come un mostro
cieco, ma dietro questo odio che porta all'orrore c'era anche questo
risentimento che si era collegato, si era accumulato in anni e anni di
prevaricazioni, di soprusi, ecc. Quindi anche lì tocca con mano la tragedia
dell'uomo contemporaneo; di questo è capace Piazzolla che, d'altro canto aveva
l'occhio anche ai fatti politici ed era vicino, anche come libertario, ai
ra-dicali. Una poesia, per esempio, è dedicata a Pannella, che io conosco anche
molto bene perché è cugino di mia moglie e quindi l'ho visto anche
recentemente. Indubbiamente questo personaggio è interessante, anzi gliel'ho
ricordato, gli ho detto: "Tu hai conosciuto di persona Marino
Piazzolla?" Ha risposto: "Sì, ma me lo ricordo poco ..." Forse
avrà avuto qualche rapporto tangenziale, rapido, veloce, ma anche questo è
significativo perché c'è anche in Piazzolla un certo radicalismo che Io ~orta,
a volte, ad essere così vivo, intenso, quando mette alla berlina questa
assurdità del capo che vuole comandare, e ricordo Maestosi che ha letto
benissimo quella poesia dove insiste, quasi martelland6 "L'ha voluto il
capo ... l'ha voluto il capo", che non è altro che un modo per ironizzare
quasi a livello sarcastico. Capo carismatico che fa tutto lui, che decide lui
per tutti: questa è anche un'altra faccia di Piazzolla.
Avevo
preparato una scaletta, come si fa in questi casi, per parlarvi un po'
ordinatamente dei miei rapporti con Piazzolla, ma devo tenere conto del tempo e
mi pare che mi sono già preso un setto-otto minuti, quindi non potrò abusarne.
Volevo
parlarvi anche un po' dell'opera che fa onore a Piazzolla e che aiuta e aiuterà
a conoscere meglio la sua opera. Non dobbiamo dimenticare che senza quest'opera,
Omaggio a Marino Piazzolla, noi non avremmo i testi sotto mano per
fare un discorso complessivo, generale su tutto il lavoro di Piazzolla. lì
secondo volume offre proprio questo di positivo:
raccoglie
tutto il discorso critico su Piazzolla, mentre nel primo volume si raccoglie
tutto quello che è di Piazzolla, cioè le poesie, i testi critici, gli
interventi sui poeti e sui pochi prosatori, (penso all'intervento su Marotta, su
Moravia), dei narratori si è occupato meno, soprattutto penso agli interventi
sui poeti.
Nel
secondo volume c'è l'opera su Piazzolla ed è utile perché ci consente di
tessere, di ricostruire questa storia della fortuna critica, cominciando proprio
dalle prefazioni. Basta vedere i nominativi, come si sviluppa il discorso della
critica, per accorgersi che in un primo tempo Piazzolla non è che sia notato
dalla critica che conta, voglio dire dai critici che già avevano allora, negli
anni Cinquanta, quando cominciò a lavorare in Italia, voce in capitolo, che
erano già autorevoli, quelli se ne accorgono semmai più tardi. Invece ci sono
altri interventi, per esempio Marotta che è un narratore e che invece sente
subito l'autenticità e la vitalità di Piazzolla; oppure un poeta straniero,
René Méjean, che diventa poi suo amico, lui lo tradurrà anche in italiano e
Mélean tradurrà in francese Piazzolla. Più tardi, nell'ultima parte della sua
vita, ci saranno altri interventi, per esempio quello di Sansone, tuttora
vivente, che è il decano della nostra letteratura: Sansone ha ben novantacinque
anni ed è veramente il decano in assoluto, ha l'età che avrebbe avuto Sapegno,
che è stato il maestro di noi che abbiamo studiato a "La Sapienza" di
Roma, oppure Bosco, anche lui, ma sono tutti scomparsi da parecchi anni, più
recentemente Sapegno.
Sansone
è ancora sulla breccia e, alcuni anni fa scrisse anche lui un suo studio sulla
poesia di Piazzolla. Oppure altri poeti, purtroppo scomparsi, come Cimatti che
era un poeta che anch'io conoscevo molto bene e ricordo che fu Enrico Falqui che
lo mandò da me quando
ancora
non era noto a nessuno. Fui tra i primi a parlare di Pietro Cimatti, un poeta
che aveva, (lo conosce bene anche Carratoni perché ha pubblicato le sue
poesie), questa grande verve, questa grande ricchezza, direi fosforescente,
questa tensione che lo portava poi a delle posizioni oltranziste al massimo,
tanto che quel suo libretto Completamente fuori, che lui mi mandò
chiedendo un giudizio, è un libretto strano, ma anche coraggioso.
In
quegli anni, erano gli anni Settanta, era un poeta che attaccava tutto e tutti,
insomma una contestazione nella dimensione anche del costume e anche una ricerca
di strade nuove, per questa poesia che deve scendere anche nell'infimo e non
solo salire alle stelle. Del resto la sensibilità e l'apertura a tutta la
realtà, l'abbiamo già detto prima, sono anche in Piazzolla; Piazzolla guarda
verso le stelle, si tende all'oltre, al metatemporale, ma guarda anche in basso.
Del resto noi sappiamo benissimo che in Dante la potenza di scatto verso
l'infinito del cielo, l'iperuranio, non ci sarebbe se non ci fosse questa
potenza di scavo dentro, fino al cuore del peccato e alla parte più torbida
dell'uomo, al male, all'inferno. Anche Cimatti è tra quelli che hanno capito
abbastanza presto l'importanza di Piazzolla e così anche altri; si potrebbe
ricordare Barberi Squarotti, che interviene anche lui un po' tardi. Ci sono qui,
poi, i frammenti di interventi di critici e anche questi hanno il loro peso:
Govoni, che era un poeta a me, fra l'altro, carissimo, perché anch'io
incominciai ad avvicinare Govoni proprio negli anni Cinquanta. lì mio primo
libretto uscì nel 1952 con la prefazione-lettera di Corrado Govoni, un poeta
che aveva questo grande candore ma questa profonda autenticità, poi segnata da
una ferita non rimarginabile, la morte del figlio Aladino. lì suo libro Aladino
è uno dei libri più belli legati alla tragedia della guerra e ai martiri
delle Fosse Ardeati ne, dove egli finì. E poi ancora altri poeti come, per
esempio, Betocchi, critici come Emilio Cecchi, che in qualche modo sono
intervenuti e poi Francesco Flora e poeti come Caproni, e giudizi che sono stati
estrapolati da lettere.
Questi
sono come piccoli tasselli, di De Libero o di Petrucciani, che è un vecchio
amico e un critico molto fine anche lui; ci sono tutti questi interventi di
critici e poi, ancora, interventi che sono stati ripresi dalle riviste, di
Marletta, di Cimatti, di Motta, c'è il saggio di Motta, uno dei primi, molto
buono, su tutta la poesia di Piazzolla. E ancora studiosi del sud, come un altro
amico e collega di università, Michele Dell'Aquila, che fa parte del centro che
ha costituito questa Fondazione, e così altri studiosi che è inutile qui
ricordare tutti e anche altri poeti, come per esempio Centore. Insomma molti
elementi che poi vengono arricchiti dagli studi, dagli interventi; i giudizi sul
pittore e disegnatore, perché c'è anche un Piazzolla pastellista che veramente
è interessantissimo, ha delle cose molto belle.
Ho
qualche quadro di Piazzolla a casa, che lui gentilmente volle donarmi (era molto
generoso) l'anno in cui vinse il "Premio Tagliacozzo" (io ne ero il
presidente), mi pare nel 1981. Era un premio che gli stava molto a cuore. lo non
facevo mai forza sulla commissione ma quell'anno riuscimmo a trovare la strada
per dimostrare (c'erano altri ottimi concorrenti) che Piazzolla meritava di
vincere il premio e lo vinse lui. Ecco un'altra occasione che mi ha consentito
di avere ancora rapporti, perché lui venne a Tagliacozzo e parlò. Poi feci
l'antologia dei Poeti a Roma con Uffreduzzi ci entrò anche Piazzolla e
fra questi c'era Tentori, Accrocca, i poeti del gruppo romano, Simongini,
Margherita Guidacci, Biagia Marniti e così via. Un'antologia ristretta dove
Piazzolla correva il rischio di essere estromesso perché nato nel 1910, per il
fatto che i poeti dovevano essere più giovani. Fui io che dissi: "Facciamo
un'eccezione, altrimenti da una parte è escluso perché è troppo in là con
anni, da quell'altra fa parte di un'altra generazione, non lo troviamo mai e
questo è ingiusto!". E così Piazzolla c'è tra I Poeti a Roma che,
appunto io ho qui, sotto mano, e da cui ho letto quel passo e ho anche riportato
una parte del giudizio che io espressi in uno studio, anche se poi nei volumi ci
sono anche altri miei interventi.
Appunto
volevo leggere, anche se, naturalmente non sono come Walter Maestosi, non sono
un attore così bravo, sono solamente un lettore di poesia, volevo leggere
almeno una poesia che mi piacque in particolare e che ho portato. Anche allora
la scelsi, ma del resto anche le altre erano bellissime. È tratta da Esilio
sull'Himalaya, che uscì nel Canzoniere, la collana di poesia diretta da
Accrocca e Vivaldi, in cui io sono apparso con le mie prime cose di poesia, Speranza
e destino del '55. L'anno precedente avevo pubblicato Fioraia
bambina, con la prefazione di Di Pino, mentre la prefazione di Speranza e
destino è di Govoni, come ho detto. In questa collana di poesia apparve
anche Esilio sull'Himalaya di Piazzolla, da cui io ho estratto questa
breve lirica che leggo per farvi sentire direttamente qualcosa del poeta.
(Lettura
di Lo ricorderemo cantando).
Questi
sono i momenti in cui la poesia di Piazzolla, tocca una sua rarefazione
intensissima, una sua trasparenza vibrante, direi magnetica quasi; questo stare
dentro il silenzio, questo legarsi all'amore, alla morte, sono due temi che
ricorrono in tutta la sua poesia. Credo che, dopo questo mio intervento,
ascolteremo ancora da Walter Maestosi la lettura di alcune poesie dell'ultimo
periodo, che sono poesie bellissime tra cui quelle scritte per la compagna
morta, e poi altre dalle raccolte pubblicate da Carratoni, che ha il merito di
avere favorito proprio in quegli anni questa possibilità di presentare la sua
nuova poesia, dell'ultimo Periodo. Alcuni testi sono anche profondamente
drammatici, quelli de Il pianeta nero, che noi abbiamo presentato;
nell'omaggio, naturalmente, troverete tutta la sua poesia raccolta, ordinata e
c'è la possibilità di ritrovarla tutta insieme. Questi due libri si completano
a vicenda perché se i testi sono raccolti nell'antologia, nella seconda parte
abbiamo tutta la parte critica che poi ha il vantaggio di offrire persino le
telefonate, le autopresentazioni, le interviste, che sono molto utili.
Quando
Marino stava per pubblicare con un editore, Cardarelli gli disse: "Beh,
andiamo, oggi devi incontrarti"- mi pare- "con Alberto Mondadori e
dobbiamo parlare, così vorrei anche fargli la proposta...". Perché, in un
certo modo, Piazzolla poteva starci benissimo ne Lo specchio" no?
Invece non è entrato ne Lo specchio e non ha avuto possibilità di
entrare presso altre case editrici di grande rilievo. Spesso ha dovuto
accontentarsi di piccole case editrici, a volte era la sua stessa casa editrice,
se la inventava lui, magari era un'autoedizione, come succede a volte a dei
poeti. Succede soprattutto quando si inizia, poi, ad un certo momento, non
dovrebbe succedere più, invece a lui succedeva fino agli ultimi tempi o quasi.
Quindi
questo editore è andato lì, si sono incontrati, non so se hanno pranzato
insieme e poi, alla fine, quando era arrivato ormai il momento di parlare di
Piazzolla, Cardarelli gli ha detto: "Ma allora? Non gli parla del
libro?" E rispose: "Mah, sarà per un'altra volta". Ma
"l'altra volta" non venne più; questo Piazzolla lo considerò un
tradimento e da allora i loro rapporti si sono guastati. La stessa cosa è
successa per altri rapporti, non so, per esempio nei confronti di Ungaretti: lui
aveva riferito, mi pare, di Gide, l'aveva presentato come un bravo flautista e
naturalmente per Ungaretti era un po' grossa. Anche nei confronti di Montale.
Certo c'è da dire chi che ha studiato bene, chi conosce storicamente questi
poeti, sa che la ragione non sta dalla parte di Piazzolla, questi sono fatti
che, semmai, ci riportano all'umore. Per esempio nei confronti di Montale trova
il modo di limitarlo, mi pare anche dopo il Nobel, e addirittura tocca il suo
pessimismo che gli pare un pessimismo quasi calc6lato, coltivato ecc.
Montale
è un grande poeta, Ungaretti, anche lui, è un grande poeta, naturalmente non
sempre della stessa statura, ma in complesso possiamo dire che è un grande
poeta. A parte che altri poeti non sono agganciati nell'interesse di Piazzolla e
si capisce anche perché, oppure è un po' per caso. Mi sembra un po' strano che
non ritorni mai l'attenzione su Clemente Rebora, questo è uno dei pochi che ho
notato. Ma per altri no, anche per Vigolo, non mi pare, ma questi che sono i
massimi, a volte vengono trattati da Piazzolla con quella violenza di dissenso
che non si può spiegare che per quelle ragioni che dicevo, per fatti di
polemica anche personale . Questo non significa che non avesse scritto anche dei
buoni articoli, ma bisogna risalire a quelli precedenti.
La
storia di Piazzolla critico va vista in questo modo: in un primo tempo Piazzolla
fa degli interventi che sono onestamente critici e si occupa di poeti
contemporanei come Cardarelli, Ungaretti; poi invece, per questi rapporti
personali la situazione cambia e non coltiva più la critica. Si dedica
completamente alla parte di invenzione, questo spiega anche i contrasti e ci
porta dentro il discorso su una personalità assai combattuta, assai complessa.
Piazzolla non è uno scrittore semplice e dovrebbe essere studiato anche il suo
linguaggio. Noi abbiamo ascoltato qui un poeta di una estrema limpidezza, che fa
pensare a quella limpidezza che è venuta fuori dalla decantazione dei poeti
dell'ermetismo, ma di certo ermetismo, perché Piazzolla non ha niente da
spartire con i manieristi, con la criptografia. Perché come lui ha scritto più
volte, la poesia non è che si debba proporre di essere capita, la poesia non
deve essere né facile né chiara di per sé, ma certamente non può astrarsi da
un margine di comunicazione che è dentro la sua stessa espressività. Purtroppo
in molti casi noi verifichiamo che il poeta troppo abile finisce per essere
prigioniero della sua stessa bravura. lo, del resto, credo che il maggiore
Ungaretti non sia da ricercarsi nelle sue cose più elaborate sottilmente nel
terzo tempo, direi che dopo il grande periodo degli inizi, dopo un grande libro
quale è Il dolore, abbiamo dei momenti in cui Ungaretti si dimostra un
finissimo artista. lo rimanevo un po' sorpreso dai colleghi quando negli anni
Cinquanta ci preparavamo alla libera docenza, che lavoravano tutti nella
direzione di quell'Ungaretti che dicevo prima, più criptografico, a cominciare
da Bigongiari, che è un eccellente critico e anche un poeta importante del
'900, ma che risentiva un po' del clima dell'ermetismo fiorentino nel quale si
era maturato.
A
Roma, invece, successe dagli anni '50 in poi maturò una poesia diversa. Negli
anni '50-'60 ci fu quella scuola romana che può essere legata al Canzoniere di
Accrocca e Vivaldi e che in qualche modo ha agganciato anche l'esperienza lirica
di Marino Piazzolla. Ma adesso vedo che non è il caso che io mi trattenga
analiticamente su queste ultime opere e piuttosto vorrei concludere, anche
perché dovremo ascoltare anche l'intervento di Carratoni, dopo una nuova
lettura, un nuovo pacchetto di testi che ascolteremo con grande piacere da
Walter Maestosi e che faranno vivere nel modo migliore questo poeta a noi caro,
un poeta che non deve essere dimenticato. lo mi auguro che questo pomeriggio
dedicato al caro amico Marino Piazzolla sia utile, in qualche modo, anche per i
giovani. Per fortuna abbiamo dei giovanissimi studiosi, come Antonella, che si
accingono a studiare in profondità Piazzolla e mi auguro che anche in altre
università accada questo. E anche al nord bisognerebbe vedere di agganciare le
università, quella di Trieste, di Padova ecc. perché questo poeta possa essere
meglio conosciuto e meglio apprezzato e in quanto credo che sia un poeta che lo
meriti veramente.
Noi
lo ricordiamo a Roma perché Roma è stata, per così dire, la sua città,
quella dove ha lavorato più a lungo. Egli si è come naturalizzato qui a Roma,
ma, effettivamente, come è già stato detto, è un poeta di respiro europeo,
internazionale, e quindi quando venne a Roma aveva già, e questo è importante,
un'educazione interna che aveva assunto a Parigi dove aveva fatto anche studi
all'università, si era laureato, specializzato, e tutto questo aveva
contribuito a portarlo fuori dall'impasse della nostra tradizione più stanca.
Un fatto singolare, che può ricordare un fenomeno contrario, è quello di
Ungaretti che va direttamente dall'Egitto a Parigi, saltando I 'Italia, e quindi
entra in un clima di tensioni e non è condizionato dalla letteratura
tardo-ottocentesca. Da noi abbiamo questo fenomeno singolare che nel primo '900,
salvo i poeti che poi esplodono ne La Voce (si ricordano Campana, Onofri,
Cardarelli, tutti i maggiori) Ungaretti e gli altri sono ancora legati a questa
tradizione che è un po’ mortificante, di conservazione, perché manca quella
spinta, manca questo innesto del seme del simbolismo-decadentismo che in Italia
ha funzionato poco, pochissimo.
C'è
una corrente espressionistica ma anche questa non si aggancia molto a quello che
succede, per esempio, in Germania, quindi l'espressionismo che si verifica in
Italia, per esempio in Rebora (ci sono di Rebora delle poesie bellissime di
segno espressionista ),è un espressionismo che nasce dall'interno della sua
carica straordinaria di dolore, di dolore per la guerra e quindi viene fuori
questo stile direi quasi autoctono, non collegabile alle correnti esterne.
Piazzolla ha
risentito delle correnti d'oltralpe ma ad un certo punto e le sue invenzioni ci
conducono soprattutto dentro questo istinto che lo portava all'invenzione della
poesia e che, dobbiamo dire, ci fa riconoscere in lui un poeta di razza e noi in
questo modo vogliamo, oggi, ricordarlo augurandoci che la sua presenza acquisti
via via maggior rilievo nelle storie della nostra letteratura.