La lunga vita di studi e riconoscimenti
da La Gazzetta del Mezzogiorno, 16 Ottobre 2005

Nella foto, Michele Dell'Aquila
E' morto ieri Michele Dell’Aquila,
professore emerito della Università
di Bari, già ordinario
di Letteratura italiana nella Facoltà di
Magistero, della quale è stato preside
per dodici anni, dal 1983 al 1995. Nonché
prestigioso collaboratore e critico
militante della «Gazzetta». I funerali
si svolgeranno lunedì mattina presso
la cappella dell’Ateneo di Bari (ore 11).
Dell’Aquila era nato a Castelluccio
Valmaggiore (Fg) il 26 marzo del 1926.
Fondatore e primo direttore del Dipartimento
di Linguistica Letteratura e
Filologia moderna della Università di
È Bari, presidente dell’Accademia Pugliese
delle Scienze, condirettore delle riviste
«Italianistica» e «Rivista di Letteratura
Italiana», direttore della rivista «La
nuova Ricerca», il critico letterario ha
conseguito numerosi premi letterari e la
medaglia d’oro del Presidente della Repubblica
per i Benemeriti della scuola
della cultura e dell’arte, il Sigillo d’oro
della Universtità degli studi di Bari.
Le sue ricerche sono stati orientate
nello studio di tematiche sette-novecentesche:
in particolare il romanticismo italiano,
Manzoni, Di Breme, Foscolo,
Leopardi, la Scapigliatura, la scrittura
poetica e narrativa del ’900, Dante, gli
svolgimenti della questione della lingua,
i rapporti tra letteratura delle regioni
storiche, soprattutto meridionali,
e la letteratura nazionale. Ha pubblicato,
tra l’altro, tre volumi sulla ricerca
linguistica di Manzoni, quattro
raccolte di saggi leopardiani, due volumi
di saggistica sette-novecentesca,
due d’interesse meridionale e pugliese,
due volumi di letture dantesche,
saggi su De Sanctis, Giannone, Paolo
Beni, Scotellaro, Sinisgalli, Dessì, Saba,
Alvaro,Tozzi, sulla cultura in Puglia
e in Bari tra Sette e Novecento.
Addio a Dell'Aquila
La letteratura della puglia nel cuore
di Raffaele Nigro
da La Gazzetta del Mezzogiorno, 16 Ottobre 2005
La gratitudine a Michele Dell’Aquila per tutto quello che ci ha dato come maestro di critica credo gliela tributassimo già da molti anni, quando ne seguivamo gli insegnamenti e quando per primo decideva di occuparsi della letteratura pugliese, per innestarla nel fiume di quella nazionale. Fu uno dei primi ad interessarsi infatti di Marino Piazzolla, di Nino Casiglio, di Pasquale Soccio e Cristanziano Serricchio. Uno dei primi ad organizzare convegni in Capitanata, prima che nascesse anche l’idea dell’università di Foggia.
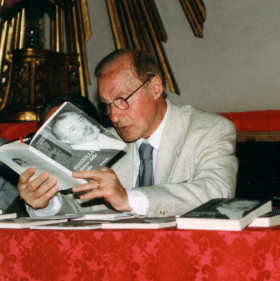
Nella foto, Michele Dell'Aquila
Questo impegno civile è nato
credo al tempo in cui Michele
Dell’Aquila fu chiamato da Mario
Sansone a far parte di quella
scuola di critica letteraria che si
fonda sul legame tra scrittura e
questioni sociali. Dell’Aquila ne
ereditò la passione per la militanza.
Che significa analisi della
scrittura creativa nel momento
in cui questa si viene formando,
allorché interagisce con altre
forme d’arte, lotta con la tradizione
e cerca nuove strade. La
critica non poteva fermarsi solo
agli studi delle biografie chiuse,
doveva osare, intervenire sul
presente. Scandagliare ciò che era
già storicizzato ma operare il
rischio della scelta e soprattutto
partecipare al dibattito sul presente,
forti di un metodo critico
fondato sulla conoscenza degli
antichi, per non essere assenti
sulle linee politiche e culturali
del momento, partecipare al dibattito
sul rapporto tra intellettuali
e potere, tra creatività, economia
e politica. Sporcarsi col
quotidiano e con i quotidiani,
quando ancora non erano dilagate
le lauree in scienza della comunicazione.
Rinnovare la figura
dell’intellettuale accademico
e provare a offrire indicazioni
di percorso sulla nuova
narrativa, sulla poesia in gestazione. Insomma rischiare e comportarsi
da apripista.
Michele Dell’Aquila si sottopose
a questa forma di operatività
già dagli anni Settanta. Dalle
antologie di Poesia e letteratura
per i licei e gli istituti magistrali
e dalla curatela di Alfieri,
Manzoni, Leopardi. Aveva interpretato
l’Orlando Furioso e
la Gerusalemme Liberata per
un pubblico giovane e si esercitava
nell’ arte della divulgazione.
In un certo senso era una
prova generale per quell’attività
che avrebbe esercitato sulla
«Gazzetta del Mezzogiorno» per
anni.
Furono quelli gli anni in cui
Dell’Aquila scopriva la propria
vocazione, l’Ottocento letterario:
La poesia di Camerana (Bari,
1968); Critica e letteratura in
tre hegeliani di Napoli: S.Gatti,
S. Cusani, G. B. Aiello ( Bari,
1969); L’esperienza lirica della
Scapigliatura (Bari, 1972); i tre
saggi su Leopardi (Bari, 1978).
Poi la folgorazione, nel sodalizio
con Sansone, la chiamata all’Università
di Bari. Sulla linea
del maestro scopre la letteratura
regionale ed ecco un affondo sul
corregionale di Ischitella nella
Difficile vita col Principe di
Pietro Giannone (Milano, 1978),
sul quale tornerà più tardi col
volume Giannone, De Sanctis,
Scotellaro: ideologia e passione
in tre scrittori del Sud (Napoli,
1981).
Ricordo gli anni Ottanta,
quando Dell’Aquila cominciava
ad invitare scrittori e poeti alle
sue lezioni, l’amicizia con Vittore
Fiore, la lettura di Tommaso
Fiore e di Biagia Marniti, la rilettura
di Comi insieme a Michele
Tondo, i convegni su Sinisgalli
e Bodini. I suoi malumori di
fronte a uno Scotellaro ridotto a
santino dalle urgenze politiche e
la necessità di leggere nel poeta
di Tricarico elementi di decadentismo
e di inquietudine, la
sua fuga da una icona neorealista.
Interpretazioni che gettarono
nuova luce su un poeta ormai
ridotto a uso e consumo di
questa o di quella compagine
politica.
Intanto Dell’Aquila andava
costruendo la sua scuola, insieme
a Ruggero Stefanelli, a Gigliola
De Donato, che con lui
suggeriva la necessità di guardare
alla scrittura del Sud, innamorata
com’era di Carlo Levi.
Una scuola parallela a quella
di una ben più agguerrita formazione
presente nella Facoltà
di Lettere. Una scuola in controtendenza
con l’impostazione
cattolica della Facoltà di Magistero
e più aperta al laicismo.
Non era facile in quegli anni. Una
scuola che andava di pari
passo con la grande ala dei sansoniani
di Lettere e di Lingue,
Francesco Tateo, Arcangelo
Leone De Castris,Vitilio Masiello.
Era quella degli anni Ottanta
anche la stagione nella quale
Dell’Aquila scopriva il mezzo
radiofonico e divulgava per la
Rai-Puglia Fatti e figure di storia
pugliese tra Sette e Ottocento
(pubblicati più tardi presso
Congedo di Galatina) e poi quel
Parnaso di Puglia nel ’900 (da
Adda, 1983) che, sebbene con una
sorta di salvagente collocato
proprio nel titolo, quasi a mettere
le mani avanti con un pizzico
di ironia, inaugurava un nuovo
corso e apriva finalmente gli
studi accademici all’universo
misconosciuto della letteratura
regionale. Era una forma nuova
di meridionalismo. Così la
scuola di Bari si legava a quella
salentina, che per una maggiore
aderenza al sentimento dell’identità
culturale ha sempre avvertito
più forte il richiamo alla
difesa dei propri valori letterari,
se è vero che Marti e Valli hanno
creato e sostenuto le edizioni della
Biblioteca Salentina di Cultura,
se Bonea e Tondo si sono occupati
di Comi, Bodini e Corvaglia.
Dell’Aquila ha rilanciato il discorso
sull’Illuminismo garganico
e su autori come Cassieri e
Palumbo, sugli italo-americani
e sui dialettali, da Tusiani a Borazio,
una ricostruzione del Novecento
pugliese continuata nella
Humilemque Italiam: studi
pugliesi e lucani di cultura letteraria
tra Sette e Novecento
(Roma, 1985). È stato sicuramente
il più sansoniano tra gli
allievi di Sansone: nel momento
in cui ha accettato di imbrigarsi
in questioni che guardavano il
presente, la politica culturale, la
vita delle nostre regioni. Come lo
è stato quando ha accettato di
presentare in catalogo pittori e
scultori, da Di Pillo a Spizzico,
da Damiani a Grassi, mostrando
in questo anche una vena
creativa, quel tanto che può favorire
la critica d’arte, commistione
di sensibilità, di intuizione.
O quando ha accettato di far
parte di giurie di premi letterari,
dal «Premio Adelfia» al «Penne
», al «Dessì» e al «Premio Bari
», spiegando che gli studi, la
strada e la vita sono tutt’uno, come
è un tutt’uno quel miracolo
quotidiano di creatività e di riflessione
che chiamiamo scrittura.
Il luogo dei segni, dei simboli
e dei sentimenti per i quali avverto
una profonda gratitudine
e un più grande affetto per quest’uomo
che ha segnato la giovinezza
di molti di noi.
Raffaele Nigro